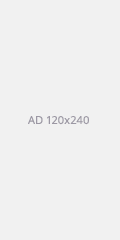Le lingue cominciano a casa; e dunque comincerò con la storia del mio coinvolgimento con le molte lingue e con il modo in cui l’uso delle lingue, che non erano quelle che avrei dovuto normalmente parlare o usare scrivendo poesie o prosa, mi influenzarono. Comincerò con alcune informazioni sulla mia famiglia e le sue lotte sullo stesso agomento.
Mia madre era greca di Smirne, quando Smirne, prima della Prima Guerra Mondiale, era una città prevalentemente greca, una comunità che parlava greco all’interno dell’Impero Ottomano. Mio padre era arabo. Era nato a Damasco in Siria. All’età di dodici anni entrò al War College, l’Accademia Militare di Istanbul. Era verso la fine del XIX secolo. Damasco era parte dell’Impero Ottomano e mio padre era un ufficiale ottomano. Essendo la Turchia alleata del Kaiser tedesco, mio padre venne istruito in turco, tedesco e francese, oltre ai suoi studi in arabo. Nell’Impero Ottomano il francese veniva insegnato per cultura generale, per la stessa ragione per cui veniva insegnato in Russia.
Mio padre, che era musulmano, sposò mia madre che, molto più giovane di lui, rappresentava anche una diversa cultura. Si era agli inizi della Prima Guerra Mondiale, intorno al 1916. Così mi fu detto. Fra di loro parlavano turco; tutti i greci che vivevano in Turchia parlavano un po’ di turco ed usavano il greco solo in casa e nelle loro scuole. Le loro esistenze erano strettamente collegate alla loro chiesa, e cultura e religione si intrecciavano l’una con l’altra. C’erano pochissimi matrimoni al di fuori del proprio gruppo culturale.
L’Impero Ottomano era un “impero”, il che significa che non si trattava di uno stato con una popolazione che costituiva un gruppo unificato. Era un impero in cui il turco non era nemmeno la lingua più parlata. Il turco stesso era una lingua piena di parole ed espressioni arabe, dato che i turchi, essendo musulmani, imparavano il Corano in arabo. C’erano anche gli Armeni nell’Impero che parlavano sia armeno che turco. Così, quasi tutti conoscevano altre lingue oltre la propria, ma ciascuno era radicato nella lingua e nella vita della propria comunità.
 Dunque, come ho detto, i miei genitori avevano in comune la lingua turca. Mia madre aveva frequentato la scuola in un convento fino all’età di dodici anni; i francesi avevano conventi in tutte le città più importanti e le persone “colte” imparavano il francese. Un po’ di francese, almeno. Quindi i miei genitori capivano il francese, sapevano come leggerlo e scriverlo. Mia madre parlava il turco ma non lo aveva studiato. Così quando mio padre era sul fronte dei Dardanelli, vicino ad Istanbul, per un periodo abbastanza lungo ed in occasione di un’importante battaglia, le scriveva lettere in francese. Era una lingua romantica, sull’onda dei romanzi tedeschi, austriaci o russi dell’epoca. Molti anni dopo, dato che queste lettere erano state gelosamente e attentamente conservate da mia madre ed erano per lei motivo di gioia e orgoglio, ebbi modo di leggerle. Avrebbero potuto essere state scritte in un libro come “Guerra e pace” di Tolstoj: parlavano di amore, di guerra, di vita e di morte. Erano state scritte al suono dei cannoni, con inchiostro nero e una grafia che disegnava le lettere dell’alfabeto con estrema chiarezza. Oggi sono andate perdute a causa dei miei molti spostamenti e della disattenzione della mia gioventù.
Dunque, come ho detto, i miei genitori avevano in comune la lingua turca. Mia madre aveva frequentato la scuola in un convento fino all’età di dodici anni; i francesi avevano conventi in tutte le città più importanti e le persone “colte” imparavano il francese. Un po’ di francese, almeno. Quindi i miei genitori capivano il francese, sapevano come leggerlo e scriverlo. Mia madre parlava il turco ma non lo aveva studiato. Così quando mio padre era sul fronte dei Dardanelli, vicino ad Istanbul, per un periodo abbastanza lungo ed in occasione di un’importante battaglia, le scriveva lettere in francese. Era una lingua romantica, sull’onda dei romanzi tedeschi, austriaci o russi dell’epoca. Molti anni dopo, dato che queste lettere erano state gelosamente e attentamente conservate da mia madre ed erano per lei motivo di gioia e orgoglio, ebbi modo di leggerle. Avrebbero potuto essere state scritte in un libro come “Guerra e pace” di Tolstoj: parlavano di amore, di guerra, di vita e di morte. Erano state scritte al suono dei cannoni, con inchiostro nero e una grafia che disegnava le lettere dell’alfabeto con estrema chiarezza. Oggi sono andate perdute a causa dei miei molti spostamenti e della disattenzione della mia gioventù.
Io nacqui a Beirut in Libano, perché alla fine della Prima Guerra Mondiale i miei genitori lasciarono la Turchia e si stabilirono a Beirut. Beirut era vicina a Damasco, città natale di mio padre. Molti anni dopo nacqui in un mondo completamente diverso da quello che i miei genitori conoscevano. Gli Alleati avevano occupato e diviso l’Arabia Orientale; i francesi tennero per loro una regione che suddivisero in Siria e Libano. Immediatamente diedero origine, in Libano, ad una serie di scuole gestite da preti, frati e suore francesi.
Così frequentai la scuola di un convento francese e fui educata in francese. I bambini della mia generazione videro un paese governato dai francesi che goderono, a causa della loro lingua e dei loro costumi, del prestigio da sempre attribuito al Potere. Studiavamo sugli stessi libri dei ragazzi francesi in Europa, la capitale del mondo sembrava essere Parigi e imparavamo i nomi di ogni genere di cosa che non avevamo mai sentito o visto: fiumi francesi, montagne francesi, la storia di un popolo dagli occhi azzurri che aveva costruito un impero. Le suore francesi, le cui famiglie avevano appena subito l’invasione delle armate del Kaiser, odiavano i tedeschi e ci trasmisero quest’odio… e così via. In un certo senso respiravamo un’aria in cui sembrava che essere francese significasse essere superiore a chiunque altro, e poiché ovviamente non eravamo francesi, la cosa migliore da farsi era almeno parlare francese. Poco a poco, un’intera generazione di ragazzi e ragazze istruiti si sentì superiore ai ragazzi più poveri che non andavano a scuola e parlavano solo arabo. L’arabo era il sinonimo di arretratezza e vergogna. Anni dopo seppi che la stessa cosa succedeva in tutto l’impero francese: in Marocco, Algeria, Tunisia, Africa Nera ed Indocina.
Il metodo usato per insegnare il francese ai bambini era di per sé una specie di condizionamento psicologico contro il quale nessuno fece mai obiezioni, la gente pensava che qualsiasi cosa facessero le suore fosse sempre buona e per il meglio. In tutte le scuole gestite dai francesi alcuni studenti scelti erano incaricati di “spiare” gli altri: chiunque fosse stato scoperto a parlare arabo, in classe o durante la ricreazione, era punito e gli veniva messa una piccola pietra in tasca; parlare arabo era associato alla nozione del peccato. La maggior parte dei ragazzi a casa parlava arabo, ma quando a loro volta diventavano genitori cominciarono a parlare sia in arabo che in francese ai loro filgi, o in un miscuglio delle due lingue.
Riandando indietro alla mia infanzia, fin da quando posso ricordare parlavo greco e turco fino ai cinque anni, periodo in cui iniziai la scuola. Il fatto che a scuola parlavo francese, e che in città c’erano dei residenti francesi – alcuni dei quali nostri vicini con i quali mia madre usava il francese che aveva imparato a Smirne nella sua infanzia – fece sì che la nostra famiglia usasse sempre più il francese anche in casa: con gioia di mia madre e riluttanza di mio padre. Anche per questo c’erano valide ragioni: mio padre era un arabo in un paese arabo e parlava arabo quando trattava i suoi affari in città o con i suoi amici. Mia madre, non conoscendo l’arabo, si identificava in qualche modo con i francesi, sebbene non avesse mai pensato che essere greca la rendesse simile a loro. No, lei semplicemente conosceva la loro lingua, in maniera imperfetta, e la usava, e cominciò ad usarla anche con me, unica figlia del suo matrimonio.
 Ricordo che mio padre, che era un uomo anziano per la bambina che ero e somigliava più ai nonni degli altri ragazzi, all’improvviso, come chi si sveglia da un sogno, cominciò a preoccuparsi e a dire a mia madre cose del tipo: “noi non siamo in Francia e tutto questo parlare francese non va bene. Questa bambina dovrebbe imparare l’arabo”. Lei rispondeva: “Perché non glielo insegni?” e lui restava in silenzio, o diceva qualche parola in arabo, parola che sembravano essere inghiottite dall’intera casa. Quando avevo sei o sette anni ricordo che mio padre aveva una penna stilografica che gli piaceva particolarmente; di tanto in tanto doveva compilare dei documenti amministrativi, e poiché l’arabo era la lingua ufficiale, scriveva, in modo regolare ed elegante, righe e righe in una lingua che per me non era né familiare né estranea. Mi insegnò l’alfabeto arabo, e me lo fece copiare forse un centinaio di volte. Io disegnavo le lettere con impegno.
Ricordo che mio padre, che era un uomo anziano per la bambina che ero e somigliava più ai nonni degli altri ragazzi, all’improvviso, come chi si sveglia da un sogno, cominciò a preoccuparsi e a dire a mia madre cose del tipo: “noi non siamo in Francia e tutto questo parlare francese non va bene. Questa bambina dovrebbe imparare l’arabo”. Lei rispondeva: “Perché non glielo insegni?” e lui restava in silenzio, o diceva qualche parola in arabo, parola che sembravano essere inghiottite dall’intera casa. Quando avevo sei o sette anni ricordo che mio padre aveva una penna stilografica che gli piaceva particolarmente; di tanto in tanto doveva compilare dei documenti amministrativi, e poiché l’arabo era la lingua ufficiale, scriveva, in modo regolare ed elegante, righe e righe in una lingua che per me non era né familiare né estranea. Mi insegnò l’alfabeto arabo, e me lo fece copiare forse un centinaio di volte. Io disegnavo le lettere con impegno.
In seguito, per un po’ di tempo, usò una vecchia grammatica arabo-turca sopravvissuta alla sua vita avventurosa. Era orgoglioso di dirmi che quella era la stessa grammatica arabo-turca che lui aveva usato all’Accademia Militare quando era cadetto: il libro era grosso e stretto, con pagine giallastre, e la copertina era piena di scritte. Su quel libro imparai a declinare verbi e brevi frasi che spiegavano l’uso delle forme verbali. A volte ero annoiata o distratta; lui mi rimproverava con gentilezza, ma perdeva la pazienza molto presto, e usando mia madre come testimone diceva: “è inutile, è una cosa che dovrebbe fare la scuola, e queste monache sono propagandiste. Tutto è propaganda in questo paese!”. Stanco di dare lezioni fuori programma, e forse, e più seriamente, essendo un uomo sconfitto in guerra, testimone della fine dell’impero per cui aveva combattuto, era stato ferito e decorato, questo ufficiale ottomano non era un pedagogo: un giorno mi disse di sedermi e copiare il libro di grammatica, pagina dopo pagina: “copia queste lezioni, mi disse, e imparerai l’arabo”.
Ricordo che allora di tanto in tanti (durò un anno, due anni, una sola stagione? Non saprei dire) mi sedevo e copiavo – cioè riproducevo fedelmente, parola dopo parola di cui capivo l’alfabeto, ma raramente il significato – senza mai cercare di capire cosa stessi scrivendo: credo che amassi il solo atto di scrivere cose che non capivo, e fingevo di imparare una lingua senza alcuno sforzo, semplicemente scrivendo. Doveva esserci qualcosa di ipnotico in quegli esercizi perchè molto più tardi, e per diverse ragioni, finì col fare praticamente la stessa cosa. Ma di questo parlerò più avanti.
 Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale frequentavo la scuola secondaria. Vidi la città di Beirut diventare una città internazionalmente importante. Gli eserciti francesi e britannici avevano i loro quartieri generali e il carattere cosmopolita del luogo scintillava di quello speciale romanticismo a cui ci avevano preparato i film. A una popolazione che includeva comunità di Greci, Italiani, Armeni e Curdi, oltre alla popolazione nativa, si aggiunsero truppe di diverse nazionalità che costituivano l’Esercito Alleato: Australiani, Canadesi, Neozelandesi, Africani, Polacchi liberi. Beirut diventò un microcosmo, un piccolo tornado di guerra e divertimento. Non si vedeva guerra vera ma gli eserciti che stavano facendo a pezzi il mondo. Per la ragazzina che ero, tutto ciò significava “facce” nuove, “eventi” nuovi, nuove lingue. Diventammo consapevoli dell’“importanza” della lingua inglese e alcune famiglie libanesi che erano abituate ad Alessandria e Il Cairo, che ci avevano vissuto ed erano tornate, rispazzolarono il loro inglese solo per essere nel corso della Storia. L’Università Americana di Beirut, che aveva soprattutto studenti stranieri, cominciò ad incrementare il numero degli studenti libanesi. La città che era bilingue stava diventando trilingue. Infatti, quando, circa dieci anni dopo i rifugiati palestinesi vennero in Libano, i più istruiti fra loro conoscevano l’arabo e l’inglese e l’intero quartiere degli affari della città, vicino all’Università Americana, usava l’inglese e non il francese come lingua commerciale.
Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale frequentavo la scuola secondaria. Vidi la città di Beirut diventare una città internazionalmente importante. Gli eserciti francesi e britannici avevano i loro quartieri generali e il carattere cosmopolita del luogo scintillava di quello speciale romanticismo a cui ci avevano preparato i film. A una popolazione che includeva comunità di Greci, Italiani, Armeni e Curdi, oltre alla popolazione nativa, si aggiunsero truppe di diverse nazionalità che costituivano l’Esercito Alleato: Australiani, Canadesi, Neozelandesi, Africani, Polacchi liberi. Beirut diventò un microcosmo, un piccolo tornado di guerra e divertimento. Non si vedeva guerra vera ma gli eserciti che stavano facendo a pezzi il mondo. Per la ragazzina che ero, tutto ciò significava “facce” nuove, “eventi” nuovi, nuove lingue. Diventammo consapevoli dell’“importanza” della lingua inglese e alcune famiglie libanesi che erano abituate ad Alessandria e Il Cairo, che ci avevano vissuto ed erano tornate, rispazzolarono il loro inglese solo per essere nel corso della Storia. L’Università Americana di Beirut, che aveva soprattutto studenti stranieri, cominciò ad incrementare il numero degli studenti libanesi. La città che era bilingue stava diventando trilingue. Infatti, quando, circa dieci anni dopo i rifugiati palestinesi vennero in Libano, i più istruiti fra loro conoscevano l’arabo e l’inglese e l’intero quartiere degli affari della città, vicino all’Università Americana, usava l’inglese e non il francese come lingua commerciale.
Le Università creavano aree culturali intorno a se stesse e Beirut ruotava intorno a tre Università che rappresentavano tre culture, tre stili di vita, tre opinioni intellettuali, direi tre destini. E, come c’era da aspettarsi, scrittori, riviste letterarie, persino i giornali, seguirono la tendenza. Naturalmente si trattava di una specie di ricchezza, un’apertura sul mondo, un’eccitante diversità. Ma allo stesso tempo creò, in un paese troppo piccolo per assorbire facilmente un così forte vento di cambiamento e frammentazione culturale, sottocorrenti di tensione che sarebbero esplosi nella generazione seguente distruggendola.
 Poco a poco, il Libano sviluppò un’intensa vita culturale, ma era frammentata in gruppi linguistici: c’erano importanti poeti (come George Schehadeh) che scrivevano in francese; molti scrivevano ancora in arabo e c’erano scrittori, poeti e giornalisti che scrivevano in inglese. Per un paese di tre milioni di abitanti un tale fenomeno riduceva considerevolmente i lettori per ciascun gruppo. Era un problema reale. Un poeta o uno scrittore non aveva mai la sensazione di rivolgersi all’intera nazione. Io scrivevo in francese. Cominciai a scrivere all’età di venti anni: era un lungo poema che intitolai “Le livre de la mer, “Il libro del mare”, una poesia che considera le relazioni tra il sole e il mare in una specie di erotismo cosmico. Ma anche in quel caso, in seguito, il fatto che il poema fosse scritto in francese mi pose di fronte a un problema. Di solito il mio lavoro poetico è tradotto in arabo e pubblicato in due o tre delle maggiori riviste letteerarie arabe. “Il libro del mare” non è ancora stato tradotto per la semplice ragione che il mare, come sostantivo, in francese, è femminile, e il sole è maschile. In arabo è il contrario: l’intera poesia si sviluppa seguendo la metafora del mare femmina e del sole guerriero, cioè un principio maschile. Così la poesia non solo non è traducibile, ma è, in senso concreto impensabile in arabo.
Poco a poco, il Libano sviluppò un’intensa vita culturale, ma era frammentata in gruppi linguistici: c’erano importanti poeti (come George Schehadeh) che scrivevano in francese; molti scrivevano ancora in arabo e c’erano scrittori, poeti e giornalisti che scrivevano in inglese. Per un paese di tre milioni di abitanti un tale fenomeno riduceva considerevolmente i lettori per ciascun gruppo. Era un problema reale. Un poeta o uno scrittore non aveva mai la sensazione di rivolgersi all’intera nazione. Io scrivevo in francese. Cominciai a scrivere all’età di venti anni: era un lungo poema che intitolai “Le livre de la mer, “Il libro del mare”, una poesia che considera le relazioni tra il sole e il mare in una specie di erotismo cosmico. Ma anche in quel caso, in seguito, il fatto che il poema fosse scritto in francese mi pose di fronte a un problema. Di solito il mio lavoro poetico è tradotto in arabo e pubblicato in due o tre delle maggiori riviste letteerarie arabe. “Il libro del mare” non è ancora stato tradotto per la semplice ragione che il mare, come sostantivo, in francese, è femminile, e il sole è maschile. In arabo è il contrario: l’intera poesia si sviluppa seguendo la metafora del mare femmina e del sole guerriero, cioè un principio maschile. Così la poesia non solo non è traducibile, ma è, in senso concreto impensabile in arabo.
All’inizio degli anni Cinquanta, andai a Parigi per studiare filosofia alla Sorbona e lì scrissi alcune poesie. Alla Citè Universitaire incontrai alcuni studenti americani e dopo un breve soggiorno a Beirut finii a New York, nel gennaio 1955, e pochi mesi dopo a Berkeley in California. Non mi accorgevo che cambiare università non significava semplicemente continuare gli studi da qualche altra parte. Era una totale rivoluzione del proprio modo di pensare, un piccolo terremoto nella vita di uno studente. Passare dalla Sorbona all’Università della California, a Berkeley, nel 1955, era come andare su un altro pianeta. Conoscendo già quattro lingue, più o meno efficientemene, ero consapevole della potenziale problematica della lingua? Davvero, ancora non lo so: quello che so è che arrivai a Berkeley, in un dipartimento di filosofia in un momento in cui le università anglo-sassoni erano – per rendermi le cose più difficili – coinvolte essenzialmente nella linguistica (e, devo aggiungere, logica simbolica). Non avevo pensato che le dieci parole e le cinque frasi di cui disponevo in inglese non erano una preparazione sufficiente per seguire corsi così complicati. Feci del mio meglio; lessi avidamente Time magazine, ascoltai dischi di jazz, e dopo circa sei mesi ero abbastanza integrata – almeno superficialmente – nella vita universitaria americana.
 Tuttavia, accadde qualcosa che determinò la mia vita: mi innamorai della lingua americana. Ero eccitata dal modo di parlare inglese dei californiani, dallo stile, dal gergo, dallo slang, delle pubblicazioni americane, dal linguaggio specialistico degli sports americani; ascoltare una partita di baseball o football era come entrare in un mondo segreto. Non so se mi piacessero i giochi nella loro essenza o tutto il linguaggio rituale che li accompagnavano. Ero orgogliosa di descrivere le partite agli amici usando la corretta terminologia. Ero felice di usare le espressioni idiomatiche, capire la parlata dei cowboy e delle piccole città. Sapevo, in americano, cose che non avrei potuto dire in nessuna delle altre lingue che conoscevo, poiché la mia esperienza di quelle altre lingue era limitata, o mi sembrava limitata, o erano troppo familiari per mantenere per me il senso della scoperta. Parlare in americano era come risalire l’Amazon River, pieno di pericoli, pieno di meraviglie.
Tuttavia, accadde qualcosa che determinò la mia vita: mi innamorai della lingua americana. Ero eccitata dal modo di parlare inglese dei californiani, dallo stile, dal gergo, dallo slang, delle pubblicazioni americane, dal linguaggio specialistico degli sports americani; ascoltare una partita di baseball o football era come entrare in un mondo segreto. Non so se mi piacessero i giochi nella loro essenza o tutto il linguaggio rituale che li accompagnavano. Ero orgogliosa di descrivere le partite agli amici usando la corretta terminologia. Ero felice di usare le espressioni idiomatiche, capire la parlata dei cowboy e delle piccole città. Sapevo, in americano, cose che non avrei potuto dire in nessuna delle altre lingue che conoscevo, poiché la mia esperienza di quelle altre lingue era limitata, o mi sembrava limitata, o erano troppo familiari per mantenere per me il senso della scoperta. Parlare in americano era come risalire l’Amazon River, pieno di pericoli, pieno di meraviglie.
All’Università le cose erano diverse. Fu molto dura cercare di provare interesse per i miei nuovi studi; dovevo cambiare direzione a modi di pensare e sentire profondamente radicati. Ricordo come fui sorpresa, o piuttosto scioccata, quando sentii che a uno dei miei colleghi studenti, un giovane yugoslavo, fu rifiutato il tema che aveva proposto per la sua tesi di dottorato. Voleva scrivere su Nietzsche e gli dissero che non era accettabile perché Nietzsche non era un filosofo ma un poeta (le cose sono cambiate dopo la rivoluzione culturale degli anni Sessanta e dubito che oggi quello stesso argomento proposto sarebbe rifiutato). Ma ero tanto più incapace di comprendere la decisione del Dipartimento, dato che consideravo che la filosofia, dopo Holderlin e Heidegger, trovasse la sua massima espressione nella poesia.
 In quei tempi scrivevo molto poco perché ero in uno stato di perenne scoperta: un intero nuovo mondo si apriva giorno dopo giorno, ed esso includevo la scoperta della Natura come forza, una bellezza seducente, una questione di sogni ad occhi aperti, un’ossessione. Andare in macchina sulle autostrade americane era come scrivere poesie con l’intero corpo. Non rimasi che pochi anni all’Università e non ho mai scritto la mia tesi di dottorato. Trovai lavoro in un piccolo college a Marin County, vicino San Francisco, come insegnante di discipline umanistiche. Ero felice.
In quei tempi scrivevo molto poco perché ero in uno stato di perenne scoperta: un intero nuovo mondo si apriva giorno dopo giorno, ed esso includevo la scoperta della Natura come forza, una bellezza seducente, una questione di sogni ad occhi aperti, un’ossessione. Andare in macchina sulle autostrade americane era come scrivere poesie con l’intero corpo. Non rimasi che pochi anni all’Università e non ho mai scritto la mia tesi di dottorato. Trovai lavoro in un piccolo college a Marin County, vicino San Francisco, come insegnante di discipline umanistiche. Ero felice.
La fatidica conversazione non solo liberò istantaneamente le mie mani, ma anche, come i pianeti che cambiano orbita, diresse la mia attenzione, e poi le mie stesse energie, verso una nuova forma d’arte che significava un nuovo universo di interessi. Nel tempo libero andavo al Dipartimento di Arte e cominciai a dipingere. Capii immediatamente che questo per me significava una nuova lingua e la soluzione al mio dilemma: non avevo più bisogno di scrivere in francese, avrei dipinto in arabo.
Tutto questo accadeva intorno al 1960. Con furia, diventai pittrice. Mi immersi in quella nuova lingua. L’aste astratta era l’equivalente dell’espressione poetica. Non avevo bisogno di appartenere ad una lingua di una determinata cultura ma ad una forma di espressione aperta (molti anni dopo, in un viaggio in Marocco, ebbi una conversazione con un pittore marocchino che mi disse che secondo lui il Marocco ha tanti ottimi pittori perché questo è il modo in cui i loro migliori artisti risolvono il problema della lingua, quelli della generazione cresciuta sotto la dominazione della cultura francese). Il mio spirito era libero. Capii che ci si può muovere in diverse direzioni, che la mente, a differenza del corpo, può andare simultaneamente in molte direzioni, che mi muovevo non su piani singoli ma in un mondo mentale sferico, e che a quelli che consideriamo essere problemi possono anche essere tensioni, che agiscono in modi molto più misteriosi di quanto possiamo capire. Col passar del tempo, poiché insegnavo in inglese, mi sentii sempre più a mio agio con la nuova lingua che stavo usando. Non usavo una nuova lingua, la vivevo.
 Poi ci fu il Vietnam. L’America in Vietnam. Il Vietnam nella psiche americana. La guerra in televisione. Le proteste nelle strade. La rivoluzione culturale che stava realizzandosi in America aveva nel Vietnam una delle sue origini, e una delle sue conseguenze fu che la guerra divenne anche un punto di convergenza letterario, una preoccupazione per i poeti e un argomento dinamico. I poeti scrivevano contro la guerra, o piuttosto, combattevano contro la guerra attraverso la poesia.
Poi ci fu il Vietnam. L’America in Vietnam. Il Vietnam nella psiche americana. La guerra in televisione. Le proteste nelle strade. La rivoluzione culturale che stava realizzandosi in America aveva nel Vietnam una delle sue origini, e una delle sue conseguenze fu che la guerra divenne anche un punto di convergenza letterario, una preoccupazione per i poeti e un argomento dinamico. I poeti scrivevano contro la guerra, o piuttosto, combattevano contro la guerra attraverso la poesia.
Un giorno – ero stata particolarmente colpita dalle immagini di guerra in televisione e mi sentivo stanca e scoraggiata – trovai, sul tavolo della sala dei professori, una rivista letteraria che sembrava un giornale piegato in quattro; diceva che era distribuito gratuitamente e salutava con favore la poesia come azione contro la guerra. Si trattava della S.B. Gazette (S e B stavano per Sausalito e Belvedere, due eleganti piccole città a nord di San Francisco). Tornai a casa, misi un foglio di carta nella macchina da scrivere e, quasi senza fare caso a quello che stavo facendo, scrissi una poesia: The Ballad of the lonely knight in the present-day America”, e la mandai alla S. B. Gazette. Pochi giorni dopo mi giunse un biglietto scribacchiato a matita su una pagina strappata di un notebook che diceva “poesia molto gradita” e sotto “mandane altre!” ed era firmato “Leon Spiro”. Ero un poeta anche nella lingua inglese!
Scrissi altre poesie, dettate dalle emozioni e dagli eventi e mi sentii parte di un immenso movimento di poeti americani in un momento in cui la poesia sembrava crescere in quel paese come la musica o l’erba.
Un giorno, un giornalista chiese a Robert Kennedy, forse per la decima volta, come viveva l’assenza di suo fratello. Bobby Kennedy si mise a piangere e come risposta citò il discorso di Romeo sulla bellezza di Giulietta nella notte. Fui così commossa nel vedere un uomo – in una cultura che nega agli uomini il bisogno di piangere come segno di debolezza – piangere apertamente per la morte del fratello ed esprimere attraverso Shakespeare il suo senso di profondo legame di affetto, che gli scrissi e gli dissi che sarei stata felice se avesse letto la poesia che avevo scritto, la prima, la Ballata. Ricevetti una bellissima risposta in cui mi diceva di essere stato commosso dal testo.
Cominciarono ad arrivarmi richieste di partecipazione a readings o di poesie da includere in antologie. Ebbi lettere dai poeti degli Stati Uniti o dall’America Latina che mi erano state inviate solo per scambiarsi pensieri. Era l’epoca in cui la poesia divenne, per pochi anni, l’unica religione che non aveva dio né dogmi, niente castigo o minacce, nessuna motivazione nascosta o uso commerciale, niente polizia e Vaticano. Si trattava di un’aperta fratellanza per donne, uomini, alberi e montagne.
Avanzavo nella lingua inglese come un esploratore: ogni parola veniva alla luce, le espressioni erano creazioni, gli avverbi immensamente immensi, i verbi erano frecce scoccate, una semplice preposizione come “dentro” e “fuori” un’avventura! Scrivere era uno sport, le frasi erano come cavalli che aprivano lo spazio con la loro energia e belli da cavalcare.
 I vecchi fantasmi non erano scomparsi. Il Mondo Arabo non era svanito dalle mie preoccupazioni. Al contrario. Avevo cominciato a viaggiare, durante l’estate, in Marocco, o Tunisia o in Giordania, in Siria o in Libano. Feci amicizia con molti poeti arabi che scrivevano in arabo o francese. Poesia e pittura rimanevano separate, ma un giorno decisi di scrivere o, per essere precisi, copiare poesie in arabo con l’intento di integrare “calligrafia” in uno stile di lavoro con acquerelli ed inchiostri che era contemporaneo: intrapresi così un percorso che è ancora davanti a me. Trovai dei fogli di carta giapponese piegati, come i vecchi libri di incisioni giapponesi in cui ogni pagina doppia era un’immagine legata o non legata a quelle seguenti. Emerse allora qualcosa dalla mia infanzia: il piacere di scrivere, verso dopo verso, frasi arabe che comprendevo in modo parziale: presi poesie dei più importanti poeti arabi e cominciai a “lavorarci”. Non cercai di farmele tradurre, ero soddisfatta dalla strana comprensione che ne avevo: un po’ qui e là, frasi in cui capivo una sola parola chiave; era come guardare attraverso un velo, guardare uno scenario straordinario attraverso uno schermo, come se lo schermo non cancellasse le immagini ma le sfumasse facendole sembrare ancora più misteriose di quanto fossero.
I vecchi fantasmi non erano scomparsi. Il Mondo Arabo non era svanito dalle mie preoccupazioni. Al contrario. Avevo cominciato a viaggiare, durante l’estate, in Marocco, o Tunisia o in Giordania, in Siria o in Libano. Feci amicizia con molti poeti arabi che scrivevano in arabo o francese. Poesia e pittura rimanevano separate, ma un giorno decisi di scrivere o, per essere precisi, copiare poesie in arabo con l’intento di integrare “calligrafia” in uno stile di lavoro con acquerelli ed inchiostri che era contemporaneo: intrapresi così un percorso che è ancora davanti a me. Trovai dei fogli di carta giapponese piegati, come i vecchi libri di incisioni giapponesi in cui ogni pagina doppia era un’immagine legata o non legata a quelle seguenti. Emerse allora qualcosa dalla mia infanzia: il piacere di scrivere, verso dopo verso, frasi arabe che comprendevo in modo parziale: presi poesie dei più importanti poeti arabi e cominciai a “lavorarci”. Non cercai di farmele tradurre, ero soddisfatta dalla strana comprensione che ne avevo: un po’ qui e là, frasi in cui capivo una sola parola chiave; era come guardare attraverso un velo, guardare uno scenario straordinario attraverso uno schermo, come se lo schermo non cancellasse le immagini ma le sfumasse facendole sembrare ancora più misteriose di quanto fossero.
Dove mi trovo ora?
 Smisi di insegnare nei primi anni Settanta e tornai a Beirut. Lascai gli Stati Uniti all’improvviso. Mi ritrovai in una città che stava vivendo i suoi anni migliori. Mi gettai nel bel mezzo di un vulcano attivo. Era affascinante. Mi trovavo di nuovo in un mondo che parlava francese ed arabo, ma per me per lo più francese, dato che trovai lavoro come direttore delle pagine culturali di un quotidiano di lingua francese fondato da poco. Era bello essere di nuovo nel luogo in cui sembrava si stesse svolgendo la storia araba, andare in vacanza ad Aleppo invece che nelle Sierras, conoscere meglio Il Cairo e Damasco di New York. Era riposante, era eccitante questo spostamento in un nuovo territorio. Beirut si era sviluppata così velocemente che per me era una città nuova.
Smisi di insegnare nei primi anni Settanta e tornai a Beirut. Lascai gli Stati Uniti all’improvviso. Mi ritrovai in una città che stava vivendo i suoi anni migliori. Mi gettai nel bel mezzo di un vulcano attivo. Era affascinante. Mi trovavo di nuovo in un mondo che parlava francese ed arabo, ma per me per lo più francese, dato che trovai lavoro come direttore delle pagine culturali di un quotidiano di lingua francese fondato da poco. Era bello essere di nuovo nel luogo in cui sembrava si stesse svolgendo la storia araba, andare in vacanza ad Aleppo invece che nelle Sierras, conoscere meglio Il Cairo e Damasco di New York. Era riposante, era eccitante questo spostamento in un nuovo territorio. Beirut si era sviluppata così velocemente che per me era una città nuova.
Una tragica ed orribile guerra scoppiò a Beirut nel 1975. La vita della gente esplose insieme ai palazzi e, come i pezzi degli edifici distrutti, andarono in tutte le direzioni. Alcuni di noi andarono a Parigi. I libanesi che parlavano francese andarono a Parigi. I libanesi che parlavano inglese andarono a Londra o a New York. Alcuni, per lo più per motivi di affari, andarono nei paesi arabi. Io andai a Parigi due anni dopo l’inizio della guerra, non per restarci per sempre, ma in attesa che le cose in Libano si calmassero. Le cose non si calmarono, come tutti sappiamo, andarono di male in peggio: dalla guerra civile all’occupazione. Mentre ero a Parigi, sentii una cosa terribile accaduta in Libano: una donna che conoscevo poco ma di cui avevo grande rispetto fu rapita dalla milizia cristiana, torturata ed uccisa. Non voglio raccontare qui la sua storia, ma solo che le “ragioni” della sua ordalia non erano moralmente accettabili. Scrissi un libro, un romanzo basato sulla realtà, su quel tragico episodio: Sitt Marie-Rose fu scritto e pubblicato a Parigi. In francese.
Per ragioni personali, qualche anno dopo, tornai in California, dato che tornare a Beirut sembrava essere una cosa sempre più difficile. Il giornale col quale lavoravo aveva chiuso. E c’erano da considerare altre difficoltà.
Di nuovo in California. Cosa dovevo fare in California se non dipingere e scrivere? Mi resi conto che penso meglio, con un fluire più naturale, quando non sono in lotta con l’ambiente intorno a me. Direi anzi che la mia scrittura è influenzata, o piuttosto cresce, come le piante crescono dal terreno e dall’acqua, dalla terra in cui vivo. Quindi ogni volta che scrivo in America, scrivo in inglese.
 Mi sento in esilio? Sì. Ma è passato tanto tempo, è durato così a lungo, che è diventato parte della mia stessa natura, e non posso dire di soffrirne spesso. Ci sono momenti in cui ne sono addirittura felice. Un poeta è, soprattutto, natura umana al suo stadio più puro. Ecco perché un poeta è tanto umano quanto un gatto è un gatto o un ciliegio è un ciliegio. Tutto il resto viene “dopo”. Tutto il resto importa, ma a volte non importa. I poeti sono profondamente radicati nella lingua e trascendono la lingua.
Mi sento in esilio? Sì. Ma è passato tanto tempo, è durato così a lungo, che è diventato parte della mia stessa natura, e non posso dire di soffrirne spesso. Ci sono momenti in cui ne sono addirittura felice. Un poeta è, soprattutto, natura umana al suo stadio più puro. Ecco perché un poeta è tanto umano quanto un gatto è un gatto o un ciliegio è un ciliegio. Tutto il resto viene “dopo”. Tutto il resto importa, ma a volte non importa. I poeti sono profondamente radicati nella lingua e trascendono la lingua.
Qualcuno potrebbe alzarsi e chiedermi perché non ho, ad un certo punto della mia vita, imparato l’arabo. È una domanda che a volte mi perseguita. Non voglio accusare il vecchio sistema coloniale (come ha splendidamente fatto Franz Fanon). Non sono, e non lo sono gli scrittori arabi, ad esempio nella situazione degli scrittori neri africani le cui lingue native sono state completamente sradicate sia dall’amministrazione coloniale francese che dai loro stessi governi. Gli scrittori arabi sono totalmente responsabili della lingua che usano.
Ho sempre fatto parte dello “qui e ora”. Non ho mai usato parte del tempo della mia vita di tutti i giorni per consacrare tutti i miei sforzi per imparare l’arabo come lingua completa. Quando il sole è forte e il mare è blu non riesco a chiudere le finestre ed entrare per “studiare” qualsiasi cosa. Sono una persona del presente perpetuo. Così sono rimasta “fuori”; l’arabo è rimasto un paradiso proibito. Sono sia straniera che nativa della stessa terra, della stessa madre lingua. Questo secolo ci ha detto troppe volte di stare da soli, di tagliare i legami, di non guardare mai indietro, di andare a conquistare la luna: ed è questo quello che ho fatto. Quello che faccio.
Traduzione di Raffaella Marzano
 Etel Adnan, nasce a Beirut, Libano, nel 1925, da padre siriano mussulmano e madre greca cristiana. “Beirut e Damasco” ha detto in un’intervista, “paesaggi della mia infanzia, rappresentavano due poli, due culture, due mondi diversi, ed io li amavo entrambi”. La Adnan è poetessa, scrittrice e pittrice. Scrive in francese ed inglese, ma afferma di dipingere in arabo. È certamente una delle maggiori scrittrici contemporanee e un punto di riferimento della cosidetta “diaspora araba”. Con Multimedia Edizioni ha pubblicato il bellissimo Viaggio al Monte Tamalpais, il breve saggio biografica Crescere per essere scrittrice in Libano e recentemente Nel cuore del cuore di un altro paese, tutti tradotti da Raffaella Marzano. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Vive tra Parigi, Sausalito in California e Beirut.
Etel Adnan, nasce a Beirut, Libano, nel 1925, da padre siriano mussulmano e madre greca cristiana. “Beirut e Damasco” ha detto in un’intervista, “paesaggi della mia infanzia, rappresentavano due poli, due culture, due mondi diversi, ed io li amavo entrambi”. La Adnan è poetessa, scrittrice e pittrice. Scrive in francese ed inglese, ma afferma di dipingere in arabo. È certamente una delle maggiori scrittrici contemporanee e un punto di riferimento della cosidetta “diaspora araba”. Con Multimedia Edizioni ha pubblicato il bellissimo Viaggio al Monte Tamalpais, il breve saggio biografica Crescere per essere scrittrice in Libano e recentemente Nel cuore del cuore di un altro paese, tutti tradotti da Raffaella Marzano. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Vive tra Parigi, Sausalito in California e Beirut.