
Foto di Salvatore Marrazzo
“A good poem is sometimes a “miracle”…because there are occasions
when all the elements seem to be in place: the language flows, the mood
is right and the thought spontaneous…and yet the poem doesn’t work.”
Maram al-Masri [1]
Chi come me ha potuto assistere ad alcuni dei numerosi reading che la poetessa siriana Maram al-Masri ha tenuto in Italia, non potrà non convenire che la sua presenza scenica rappresenta un valore aggiunto notevole, sia dal punto di vista estetico (alla naturale gradevolezza fisica si aggiunge una meticolosa ricercatezza “cerimoniale” degli abiti e delle acconciature) che da quello emotivo (innegabile l’effetto empatico che la sua lettura quasi sussurrata provoca negli spettatori).
A tale proposito citerei il grande poeta Adonis che di lei dice: “Maram al-Masri riesce a dare forma linguistica alla sua femminilità”; Claudio Pozzani arriva a dire che “chi ha avuto la fortuna di assistere alle sue letture in pubblico ha potuto rendersi conto che Maram è la sua poesia.” (C. Pozzani, introduzione a Ciliegia rossa su piastrelle bianche, Genova 2005, p. 6); e Giuseppe Conte dice: “Ho visto una sola volta Maram al-Masri , e una sola volta l’ho ascoltata leggere le sue poesie. Tanto è bastato per capire la qualità del suo lavoro e cogliere in lei un intreccio inscindibile di bellezza e sofferenza, come solo i poeti al mondo sono capaci di sopportare.” (G. Conte, Introduzione a Ti guardo, Multimedia, Baronissi 2009, p. 5).
Tuttavia lo scopo primario di questa rubrica è quello di invitare alla lettura di testi di poeti “lontani”, anche (o soprattutto) in loro assenza, pur essendo l’estensore consapevole che l’oralità – e quindi la voce e il corpo del poeta – è una componente originaria e fondativa della poesia. Ecco dunque spiegato il senso del titolo scelto per questo scritto: vorrei provare a verificare la tenuta di alcuni testi di Maram al-Masri sulla pagina scritta e perciò in sua assenza.
Il primo problema che si pone a chiunque legga le poesie della scrittrice siriana è quello della lingua. Infatti, come dicevamo, Maram è nata a Lattakia in Siria ed ha cominciato a scrivere in arabo, ma dal 1982 si è trasferita in Francia, adottando anche la lingua della sua seconda patria. Ecco alcune sue interessanti considerazioni espresse in un’intervista rilasciata a Le Figaro il 30 maggio 2016: “La lingua poetica è un dialogo con un assente. […]Quando vivevo in Siria, scrivevo in arabo, adesso che sono in Francia, mi esprimo in francese. […] La lingua è un veicolo come un altro. […]personalmente, mi muovo attraverso le parole. La lingua francese mi permette di toccare più persone, oggi, che la lingua araba. Non domino perfettamente né l’arabo, né il francese, ma ciò che posso dire mi permette di giungere alla mia destinazione, di parlare direttamente alle persone.” (la traduzione dal francese, qui come in seguito, salvo diversa indicazione, è mia).
Vincent Rouillon dice: “Molti poeti siriani hanno scelto di scrivere in francese, facendoci così partecipare all’incomparabile potere poetico della lingua araba. Il dono della poetessa Maram al-Masri è ancora più prezioso, perché non solo scrive nelle due lingue, ma lei ” si traduce.” Tradursi: offrire ed offrirsi usualmente all’incrocio di due sistemi simbolici esclusivi: essere al tempo stesso mistico ed agnostico, saggio e filosofa, poeta avanguardista ed aedo di sempre… Affidando alle due lingue la profondità del suo ascolto e la pienezza fragile del suo canto, conferisce generosamente al francese lo statuto di lingua di accoglienza per i rifugiati poetici.” (V. Rouillon, Maram Al-Masri, réfugiée poétique, Extrait de la Lettre d’Echanges n°79, dicembre 2011, lettera elettronica della FNCC, https://blogs.mediapart.fr/edition/le-printemps-des-poetes/article/151112/maram-al-masri-refugiee-poetique-par-vincent-rou).
Aggiungerei, su questo argomento, alcune importanti considerazioni di Annalisa Bonomo: “[…] la sua poesia ha suscitato nuovi dibattiti su come la scrittura femminile possa suonare come un elemento tramite culturale nella traduzione, in una prospettiva globalizzata che dovrebbe diminuire l’ottuso paradigma Noi / Loro ancora attivo nelle relazioni culturali internazionali.” (A. Bonomo, “Translating in a Global Perspective: The Case of Maram Al-Masri’s Poetry”, in Textus n. 3, Roma 2013).
Come molti italiani, anche io non conosco l’arabo, e ben tre dei quattro suoi più notevoli libri pubblicati in Italia (Ciliegia rossa su piastrelle bianche, [in seguito per brevità Ciliegia rossa] traduzione di François-Michel Durazzo, Liberodiscrivere, Genova 2005; Ti guardo, traduzione dall’arabo di Marianna Salvioli, Multimedia, Baronissi 2009; Arriva nuda la libertà, traduzione dall’arabo di Bianca Carlino, Multimedia, Salerno 2014) sono tradotti da questa lingua.
Proverò quindi a soffermarmi dapprima su quelle che io ritengo le principali costanti strutturali e tematiche (e di contro provando a rilevare qualche variante) nei quattro libri in questione (ai tre sopra citati va aggiunto Anime scalze, Multimedia, Salerno 2011, cura e traduzione dal francese di Raffaella Marzano), riservandomi un successivo approfondimento sui testi, privilegiando quelli scritti in francese.
 Un primo rilievo strutturale. Pozzani, nella citata introduzione a Ciliegia rossa, dice (p. 5): “[…] non è una raccolta di versi eterogenei, bensì una sorta di psicodramma a episodi o, da un’altra angolazione, una serie di pagine strappate a un diario intimo.” Ritengo che si possa estendere tale considerazione anche ai libri successivi, caratterizzati tutti da un forte intento unitario: infatti, Giuseppe Conte nell’introduzione a Ti guardo (cit., p. 5) parla di “ […] un canzoniere d’amore luccicante come perle, e tenebroso come la più nuvolosa delle notti.” E si affaccia in questo libro, forse per la prima volta, una sorta di polifonia in cui all’io del poeta si alterna quello della “piccola prostituta”, evidenziato dall’uso del corsivo.
Un primo rilievo strutturale. Pozzani, nella citata introduzione a Ciliegia rossa, dice (p. 5): “[…] non è una raccolta di versi eterogenei, bensì una sorta di psicodramma a episodi o, da un’altra angolazione, una serie di pagine strappate a un diario intimo.” Ritengo che si possa estendere tale considerazione anche ai libri successivi, caratterizzati tutti da un forte intento unitario: infatti, Giuseppe Conte nell’introduzione a Ti guardo (cit., p. 5) parla di “ […] un canzoniere d’amore luccicante come perle, e tenebroso come la più nuvolosa delle notti.” E si affaccia in questo libro, forse per la prima volta, una sorta di polifonia in cui all’io del poeta si alterna quello della “piccola prostituta”, evidenziato dall’uso del corsivo.
C’è sempre
da qualche parte
qualcuno che ci somiglia
disse la piccola prostituta
sorridendo fiduciosa
mentre guardava dalla finestra
come se vedesse
il suo sogno:
un albero carico
di frutti…
(2, Ti guardo, p. 10)
La melagrana
che serba i segreti
delle sue perle
aspetta sempre
che tu peli
la sua buccia lucente…
Alla sete è promesso
un liquido
delizioso…
(3, Ti guardo, p. 11)
Nel doppio esempio sopra citato balza evidente agli occhi del lettore – oltre alla presentazione dell’altro personaggio – la concatenazione tra le due poesie, un continuum che ribadisce quanto già detto a proposito dell’indissolubile rapporto organico tra i testi presentati.
Ancora fortemente unitario è Anime scalze, caratterizzato dalla presentazione attraverso una minima scheda in corsivo (ad es., Madame Sigard, p. 59: Madre: Yvette/ Padre: Roland/ Età: 79 anni/ Professione: ex sarta) identificativa dei personaggi che danno il titolo ad ogni poesia, e ognuno di essi parla in prima persona, dando vita dunque ad un grande concerto polifonico. “Serrato ed esteso come un poema questo libro racconta e rivela, denuncia e riflette l’umiliazione e il dolore di un gruppo folto di donne. Diverse per età e condizione, queste donne rappresentano e impersonano l’intero universo femminile che cerca una nuova vera liberazione. Chiamata ognuna per nome, come in un catalogo di esistenze straziate dalla prepotenza e dal disamore, ne udiamo le voci, ne seguiamo i gesti, le sentiamo come presenze vive, madri – figlie – sorelle, alle quali accompagnarci, delle quali condividere le attese.” (Elio Pecora, estratto dalla motivazione per il Premio Nord Sud ad “Anime scalze” di Maram al Masri).
Infine, anche Arriva nuda la libertà è una sequenza di “testimonianze” della tragica guerra civile in atto in Siria, con voci di donne, uomini e bambini. “Molti pensano che la poesia sia una questione di immaginazione e che descrivere delle immagini del mondo reale sia un esercizio banale. Mi torna in mente quanto aveva fatto Bertolt Brecht durante la guerra con il suo L’Abicì della guerra in cui ogni quartina commentava una fotografia di attualità ritagliata dai giornali. Non per glorificare la guerra, ma per mostrare, ai suoi contemporanei e per i tempi a venire, che la guerra è la più orribile delle realtà. Quel che è strano, è che io ho cominciato questo libro prima di scoprire la raccolta di Brecht…” (M. al-Masri, Introduzione a Arriva nuda la libertà, cit. p. 5)
Quindi, per tutte e quattro le raccolte si può parlare di forte unità strutturale, di “canzoniere”, mentre almeno nelle ultime tre si riscontra un’intenzionale polifonia. Questo mette in crisi la tesi di quanti hanno parlato, a proposito della poesia di Maram, di naïveté (definizione che giustamente la poetessa respinge – cfr. A. Bonomo, MARAM AL-MASRI’S POETRY IN TRANSLATION: AN INTERVIEW, Rivista di studi italiani, Anno XXIX , n° 1, Giugno 2011, http://www.rivistadistudiitaliani.it, p. 302) : infatti l’apparente semplicità del linguaggio (soprattutto delle poesie meno recenti) si colloca in una cornice che consapevolmente ne esalta le relazioni intertestuali. Possiamo altresì ricordare quanto detto dal poeta Luis Alberto de Cuenca del suo stile e della sua apparente semplicità: «La poesía de Maram al-Masri es engañosamente sencilla… Puede parecer de fácil acceso a cualquier tipo de lector, pero muy pocos son capaces de penetrar en el tejido sutilísimo de la tradición que subyace en cada verso». («La poesia di Maram al-Masri è ingannevolmente semplice… Può sembrare di facile accesso a qualunque tipo di lettore, però molto pochi sono capaci di penetrare nel tessuto sottilissimo della tradizione che si cela in ogni verso.», in ¡Maram, Maram, Maram! di Soren Peñalver, http://www.canal-literatura.com/Maram-Al-Masri.html – la traduzione dallo spagnolo è mia)
Un’altra caratteristica strutturale, rilevata da molti (Elizabeth Burns, Michael Binyon, Claudio Pozzani) è la brevità di queste poesie, tanto che alcuni hanno voluto accostarla alla poesia giapponese (“[…] all’Haiku (ma neanche sapevo cosa fosse quando iniziai a scrivere)” , dice Maram in A. Bonomo, Poesia e Mediterraneo: dialogo con Maram al-Masri., http://www.ippocrene.com/2007_to_2010/index.php?option=com_content&task=category§ionid=21&id=111&Itemid=227 ) o a Saffo. Questo è essenzialmente vero per le prime due raccolte (Ciliegia rossa e Ti guardo) a cui quei commenti si riferiscono, ma nelle successive ci vengono presentati testi più lunghi e meno frammentari, in cui l’esigenza della narrazione prevale sull’immediatezza della sintesi.
Infine vorrei sottolineare il frequente ricorso al discorso diretto, quasi un’esigenza di evitare ogni mediazione, di stabilire un dialogo ravvicinato tra un io e un tu che possono essere, di volta in volta, la donna (Maram stessa o un suo alter ego) e l’uomo, la madre e il figlio, un uomo e un bambino, l’autrice e il suo pubblico (inteso come somma di singoli individui).
Veniamo adesso alle costanti (e varianti) tematiche.
Si rischia la banalità affermando che protagoniste di tutta la produzione poetica della poetessa di Lattakia sono le donne, al punto che perfino la Libertà e la Siria vengono personificate in donne e madri. Ma è interessante approfondire il particolare punto di vista di Maram al-Masri, che costituisce fin dall’esordio una discontinuità rispetto alla tradizione – “I wrote Je te menace when I was still young; it is my first whisper of poetry. I did not even know if it was poetry or not because it was not anything like traditional poetry.” (Ho scritto Ti minaccio quando ero ancora giovane; è stato il mio primo sussurro di poesia. Non sapevo nemmeno se fosse poesia o no, perché non c’era nulla di simile nella poesia tradizionale.) Maram al-Masri in A. Bonomo, MARAM AL-MASRI’S POETRY IN TRANSLATION: AN INTERVIEW, cit., p. 302 – la traduzione è mia) – ma anche a certo femminismo di maniera.
“Non sono Shahrazàd. Lei utilizza l’immaginazione, mentre io mi servo dell’emozione ed àncoro le mie poesie nella realtà.” (Maram al-Masri, intervista rilasciata a Le Figaro, cit.). Ho scelto di evidenziare queste affermazioni perché mi sembra che siano davvero utili a capire in che modo Maram si sottragga allo stereotipo di una poesia femminile ammantata di esotismo mediorientale. Sudore, sangue, sperma, oggetti e gesti quotidiani, perfino le rughe ed i capelli bianchi, sottraggono ad un eccessivo lirismo la sua poesia fin da Ciliegia rossa , come nell’esempio che segue (p. 109):
È venuta tutta intera,
con l’odore del suo letto
e della sua cucina,
con i baci di suo marito
nascosti sotto la camicetta,
con il suo sperma
ancora caldo
nel ventre.
È venuta,
con la sua storia e i suoi sogni,
le sue rughe,
e il suo sorriso screpolato,
con la peluria che si tesse
sul bordo delle sue guance,
con i resti delle loro colazioni
appiccicati ai denti.
È venuta con tutti i miei dolori,
la donna che vive con il mio uomo.

Il già citato Adonis ha parlato di “labirinti dell’erotismo”: questa formula mi sembra particolarmente efficace per descrivere una caratteristica della poesia della scrittrice siriana, nella quale l’erotismo è sempre presente, non disgiunto però da una “tensione” (Pozzani), da una dialettica che vede spesso contrapporre la violenza maschile al desiderio ed alla liberazione sessuale della donna. Appena un paio di esempi tra i tantissimi che si potrebbero estrapolare dai libri di Maram:
M’infiamma il desiderio
e brillano i miei occhi.
Sistemo la morale nel primo cassetto che trovo,
mi muto in demonio,
e bendo gli occhi dei miei angeli
per
un bacio.
(Ciliegia rossa su piastrelle bianche, cit., p.15)
Ho osservato il mio specchio
e vi ho visto
una donna
pienamente soddisfatta
con gli occhi brillanti
d’una squisita malizia.
L’ho invidiata
(Ciliegia rossa su piastrelle bianche, cit., p.203)
Vorrei rilevare che, nelle prime tre raccolte qui considerate, lo scenario è quasi sempre un interno (casa, cucina, letto, ecc.), una situazione di reclusione domestica nella quale spesso la donna subisce violenze fisiche e psicologiche o, tutt’al più, una casa di accoglienza dove rifugiarsi (è il caso di Anime scalze che scaturisce da una serie di incontri avvenuti nella sede dell’Associazione Halte Aide Aux Femmes Battues di Parigi). Questo mi ha fatto tornare alla mente le poesie dal carcere di Nazim Hikmet – autore peraltro citato da Maram tra le sue letture giovanili, insieme a Rabindranath Tagore le cui poesie d’amore mi sembrano molto affini (cfr. M. Ponte, “Intervista alla poetessa MARAM AL-MASRI”, https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2015/04/09/intervista-alla-poetessa-maram-al-masri/ ) – nelle quali viene espresso con grande lirismo il desiderio di avere con sé la donna amata. Solo che mentre in Hikmet la reclusione ha motivi politici e l’aguzzino è un terzo rispetto alla coppia, in al-Masri la reclusione ha motivi socio-culturali e l’aguzzino è l’altro, l’uomo amato e spesso ancora desiderato, in un’irrisolta dialettica odio-amore. Talvolta l’ansia di liberazione viene espressa dall’evasione di simbolici uccelli dalla propria gabbia (e di animali simbolici – gazzella, mosca nera, leone, formiche, ragno, verme, ecc. – è costellata Ciliegia rossa):
Lei mi apre
le sue ampie porte.
Mi chiama
e mi spinge a lanciarmi
nel suo spazio
e come un uccello
davanti alla porta aperta della gabbia
non oso.
(Ciliegia rossa su piastrelle bianche, cit., p.41)
Solo con Arriva nuda la libertà lo scenario, per forza di cose, cambia completamente. Infatti, nella raccolta dedicata alla Siria, i muri, le strade, le piazze, le montagne, il cielo, conquistano inevitabilmente il centro della scena in questo quadro fortemente contrastato tra la rivendicazione della libertà e l’orrore della repressione e delle morti. 
[…]
Prima di andare a letto
i figli della Libertà
non lavano i denti
non ascoltano le favole
di principi e principesse.
Ascoltano il frastuono della paura e del freddo
sui marciapiedi
davanti alle porte delle loro case distrutte
negli accampamenti
o
nelle tombe.
I figli della Libertà
come tutti i bambini del mondo
aspettano
il ritorno della madre.
(Arriva nuda la libertà, cit., p. 67)
Altre costanti tematiche sono state evidenziate dalla Bonomo (in Poesia e Mediterraneo, cit.), ad esempio: “le “ciliegie” e i “melograni”, “il miele” e la “polvere” (quest’ultima metafora ossessiva in quasi ogni raccolta dell’autrice)”, in proposito Maram dice: “Io mi sento come la polvere: leggera e pesante, e come la polvere danzo con il tempo.” (in Arriva nuda la verità: intervista a Maram al-Masri, di Samir Galal Mohamed, La città nuova Milano, 2014 http://lacittanuova.milano.corriere.it/2014/09/20/arriva-nuda-la-verita-intervista-a-maram-al-masri/)
Ecco solo un piccolo esempio tra i tanti possibili:
Ogni volta
che apro la mia valigia,
ne esce polvere.
(Ciliegia rossa su piastrelle bianche, cit., p.51)
Abbiamo già riscontrato la tendenza al realismo ed alla narrativizzazione della poesia che, in tutta evidenza, si accentua nei due libri più recenti. A quanto detto precedentemente di Anime scalze, va aggiunto che la rassegna di personaggi è intervallata da alcuni significativi “ambienti” (La cucina, p. 45; Stanza da bagno, p. 51; Le cantine, p. 97) e che il libro si conclude con una serie di nove poesie sull’amore ed una breve – quattro poesie – sequenza finale. Vorrei leggere appunto il primo di questi ambienti La cuisine:
Dans ce lieu
les femmes passent leur vie.
En lui
souffle la tempête des cris
et l’odeur de la famille.
En lui cohabitent
le feu et la glace
le couteau et les caresses
la menthe et le miel
le sourire et les pleurs.
Lieu étroit
pour les âmes
qui se repoussent,
vaste
pour le rire et les souvenirs
les secrets dits en confidence
aux casseroles.
Avec le fumet du repas
montent les gémissements
et la vie s’arrête
pour ces femmes
qui saignent
des gouttes d’eau
et pleurent du sang.
Puis s’agenouillent pour ramasser
l’éclat
d’un sourire
b r i s é.
[Qui/ le donne passano la loro vita./ Qui/ soffia la tempesta delle grida/ e l’odore della famiglia./ Qui coabitano/ il fuoco e il gelo/ il coltello e le carezze/ la menta e il miele/ il sorriso e i pianti.// Luogo angusto/ per le anime/ respinte,/ vasto/ per le risate e i ricordi/ i segreti detti in confidenza/ alle pentole./ Con il profumo del cibo/ s’alzano i gemiti/ e la vita si ferma/ per queste donne/ che sanguinano/ gocce d’acqua/ e piangono sangue./ Poi si inginocchiano per raccogliere/ la scheggia/ di un sorriso/ i n f r a n t o.]

A differenza della rassegna di personaggi che parlano generalmente in prima persona, qui (come negli altri ambienti) la forma è impersonale, una sorta di oggettivazione, sia nel senso di una descrizione oggettiva, che in quello di una riduzione ad oggetto di ogni cosa, persone e sentimenti inclusi. Il realismo è amplificato dalla presenza di oggetti e azioni del ménage quotidiano, in cui coabitano “il sorriso e i pianti”; ma non lascia dubbi alla natura violenta del rapporto, adombrata in tutta la poesia, il “piangono sangue” che precede i quattro versi del finale che, come spesso accade in Maram, ci sorprende, qui con questa splendida figura che condensa un sentimento ed un oggetto, che normalmente sarebbe un piatto o un bicchiere e che invece è un sorriso in frantumi.
Questa commistione di oggetti e di persone si ritrova molto spesso nella sua poesia, spinta talvolta fino al limite, animistico più che simbolico, della personificazione di utensili e arredi, a cui vengono attribuiti azioni e sentimenti umani, in un chiaro meccanismo psicologico di proiezione, come per esempio:
[…]
La cassettiera respira con difficoltà
come se fosse incinta
lamenta il disordine
e la vecchiaia…
La sedia borbotta
perché da molto tempo
un ospite non condivide la sua veglia
Quanto al letto
ha nostalgia
dei mormorii
e dei sogni…
(Ti guardo, cit., p. 75)
D’altra parte, come apprendiamo dai titoli delle raccolte, perfino la Libertà è nuda e le anime hanno i piedi … nudi! (E sulla nudità in Maram si potrebbe aprire un nuovo capitolo, – “La nudità, per me, è lo stato di purezza, di verità, là dove noi siamo come i neonati. Ma è la condizione più fragile e più coraggiosa. Pertanto, sono pudica come donna e come poetessa. Ma, nella poesia mi denudo per essere autentica.” , SuccoAcido writing intervista Maram al-Masri 19 gennaio 2014 http://www.succoacido.net/new/index.asp?pag=magazine_page&art=987&gruppo=7&cat=53
– ma mi limito qui a citare questo magnifico ossimoro “[…] la veste della mia nudità/ che mi rende/ davvero/bella?” – Ti guardo, cit., p. 45)
Potremmo forse ipotizzare che il realismo di Maram al-Masri sia del genere “magico”, formula ormai abusata che tanta fortuna ha avuto in passato soprattutto nel campo della narrativa; comunque, perfino nel più crudo tra i suoi libri, c’è uno spiraglio che “magicamente” e, credo non a caso, attraverso un gesto artistico riconduce alla speranza:
[…]
Cosa sono gli uccelli?
Lo interruppe il fanciullo.
L’uomo prese una matita
e disegnò sulla parete
una finestra
e un fanciullo
con
le ali.
(Arriva nuda la libertà, cit., p. 61)

Vorrei avviarmi alla conclusione leggendo questa poesia intitolata Awu Pam, tratta ancora da Anime scalze:
Mère: Atchanok
Père: Tcheng
Âge : 32 ans
Profession : journaliste économique
Dans la salle d’attente des services sociaux
une jolie petite femme se met à me parler
d’une voix fine
avec des mots froissés comme un mouchoir.
– Excuse-moi. Moi parle français pas bien.
Cinq ans, moi vis en France,
il dit qu’il aime moi
alors moi quitté travail et famille pour lui.
– Oui… oui…
moi travaille journaliste à la télé
donne informations sur Bourse
Ah ! oui… c’est l’amour…
– Il m’a pas laissée aller à l’école
car moi pas besoin parler français, il dit
«Nous deux, parle anglais».
Pas carte crédit
C’est lui qui achète tout
«pour qu’il me repose
de la dure responsabilité de la vie. »
– Pas voiture
Et pourquoi je dois sortir de la maison
puisque j’ai pas travail ?
Oui…
il disait qu’il me protége
et moi je croyais.
Aujourd’hui,
sur mes bras une fillette.
Je veux tant rester près d’elle
dans un pays que je connais pas sa langue
et un mari
qui a forcé la vie à m’oublier.
[Madre: Atchanok/ Padre: Tcheng/ Età : 32 ans/ Professione : giornalista finanziario// Nella sala d’attesa dei servizi sociali/ una graziosa piccola donna comincia a parlarmi/ con una voce sottile/ con parole sgualcite come un fazzoletto.// Mi scusi. Io non parlare bene francese/ Cinque anni, io vivo in Francia,/ dice che mi ama/ allora io lasciare lavoro e famiglia per lui./ Sì… Sì…/ mio lavoro giornalista alla televisione/ do informazioni sulla Borsa/ Ah! sì… è l’amore…/ Lui non permesso me andare a scuola/ perché io no bisogno parlare francese, lui dice/ “Noi due, parlare inglese”.// Niente carta di credito/ è lui che compra tutto/ “perché lui mi risparmia/ le dure responsabilità della vita.”// Niente macchina/ E perché devo uscire di casa/ dato che non lavoro?/ Sì…/ diceva di proteggermi/ e io ci credevo.// Oggi,/ fra le mie braccia una bimba./ Voglio tanto restare con lei/ in un paese che non conosco la lingua/ e un marito/ che ha costretto la vita a dimenticarmi. – Anime scalze, cit., pp. 16-19, traduzione Raffaella Marzano]
 Una poesia che mi sembra emblematica del rapporto empatico che Maram stabilisce con le sue interlocutrici/personaggi, fino all’identificazione: le difficoltà di vivere in un paese straniero, i problemi con la nuova lingua, l’illusione dell’amore, le vessazioni subite, il forte sentimento di maternità. Il realismo qui si spinge al limite della mimesi (oltre alla scheda di identità, il calco del linguaggio sgrammaticato, le pause e le esclamazioni tipiche del parlato, ecc.), ma non è una fredda riproduzione, piuttosto la replica (che purtroppo potrebbe andare avanti all’infinito) di un vissuto che appartiene tutto intero anche all’autrice, che perciò riesce a trasmetterne tutto intero a noi lettori il carico emozionale.
Una poesia che mi sembra emblematica del rapporto empatico che Maram stabilisce con le sue interlocutrici/personaggi, fino all’identificazione: le difficoltà di vivere in un paese straniero, i problemi con la nuova lingua, l’illusione dell’amore, le vessazioni subite, il forte sentimento di maternità. Il realismo qui si spinge al limite della mimesi (oltre alla scheda di identità, il calco del linguaggio sgrammaticato, le pause e le esclamazioni tipiche del parlato, ecc.), ma non è una fredda riproduzione, piuttosto la replica (che purtroppo potrebbe andare avanti all’infinito) di un vissuto che appartiene tutto intero anche all’autrice, che perciò riesce a trasmetterne tutto intero a noi lettori il carico emozionale.
Tuttavia, come abbiamo già visto, c’è spesso nella poesia di Maram al-Masri un colpo di coda che capovolge la situazione, e dunque anche io voglio terminare con le sue parole, due brevi citazioni che ci aiutano ad uscire dallo stato depressivo in cui i racconti di tante sofferenze potrebbero averci condotto:
Ogni volta che un uomo
mi abbandona
divento più bella
(Ti guardo, cit., p. 107)
Grazie a tutti quelli
che mi hanno amato
e a tutti quelli che mi hanno detestato
a quelli che mi hanno abbandonato
e a quelli che ho abbandonato
Ogni volta mi hanno ridato fuoco
e riacceso in me il desiderio
Ci sono quelli che ho dimenticato
e quelli che non dimenticherò mai
Non mi hanno impedito
d’avventurarmi
ogni volta
ad amare di nuovo.
( Anime scalze, cit., p. 179)
In conclusione posso quindi affermare che il “miracolo” della poesia si avvera anche sulla pagina scritta, senza la carismatica presenza di Maram al-Masri, anche se mi auguro, e vi auguro, di poter ancora spesso incontrare questa affascinante poetessa siriana ed ascoltare vecchie e nuove poesie nel sussurro della sua lingua flautata.
Giancarlo Cavallo
[1] “Una buona poesia è a volte un “miracolo” … perché ci sono occasioni in cui tutti gli elementi sembrano essere a posto: il linguaggio fluisce, l’umore è giusto e il pensiero spontaneo … eppure la poesia non funziona.”. Maram al-Masri in A. Bonomo, MARAM AL-MASRI’S POETRY IN TRANSLATION: AN INTERVIEW, cit., p. 300 – la traduzione è mia.

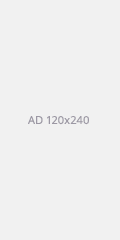
Commenti recenti